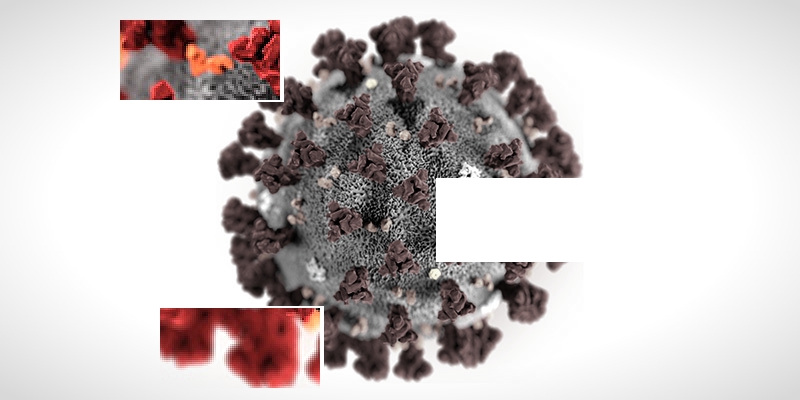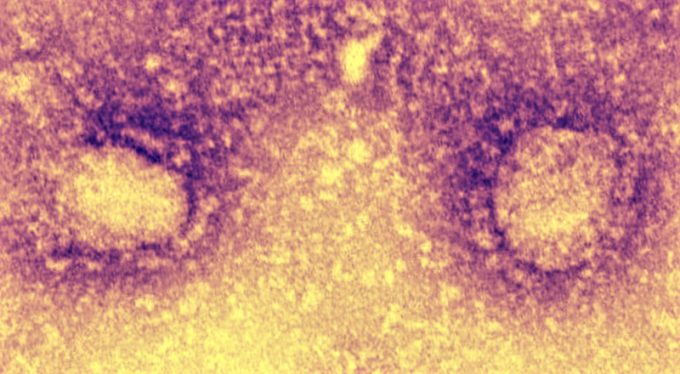È il più completo diffuso finora: tra i 1.600 casi gravi esaminati un paziente su quattro è morto dopo il ricovero, e i tempi di degenza per chi sopravvive sono spesso lunghi.
Un gruppo di medici e ricercatori che lavorano in Lombardia ha pubblicato una prima indagine sulle caratteristiche e gli esiti di quasi 1.600 ricoveri nelle unità di terapia intensiva, effettuati nelle ultime settimane negli ospedali lombardi a causa delle infezioni da coronavirus. Lo studio, uno dei più completi finora diffusi sui casi della Lombardia, è stato pubblicato sulla rivista scientifica JAMA e mostra quanto la COVID-19 comporti lunghi periodi di degenza nelle terapie intensive, con un’incidenza piuttosto alta dei decessi soprattutto tra i pazienti più a rischio (anziani e con precedenti malattie).
Nell’80 per cento dei casi circa la COVID-19 causa sintomi piuttosto lievi, come febbre e tosse secca, che possono essere trattati a casa con i comuni farmaci da banco. Il restante 20 per cento manifesta invece sintomi più seri, soprattutto ai polmoni, che possono rendere necessario il ricovero in ospedale. Nei casi più gravi si fa ricorso all’intubazione nelle unità di terapia intensiva, per aiutare i pazienti a respirare meglio e ad affrontare i sintomi della malattia, in attesa che il sistema immunitario impari a riconoscere e a sconfiggere il coronavirus.
Lo studio, che ha come primo firmatario Giacomo Grasselli del Policlinico di Milano, ha utilizzato i dati raccolti dalla rete delle terapie intensive organizzata dalla Regione Lombardia per coordinare i ricoveri negli ospedali lombardi, e che soprattutto nelle prime settimane dell’emergenza sanitaria ha dovuto gestire centinaia di nuovi casi gravi ogni giorno.
I pazienti compresi nell’indagine avevano ricevuto una diagnosi di COVID-19 tramite test di laboratorio, ed erano stati trasferiti in una delle terapie intensive dei 72 ospedali della Lombardia compresi nella rete di coordinamento. I dati fanno riferimento a quasi un mese di attività, da metà febbraio a metà marzo, comprendendo quindi l’inizio dell’epidemia italiana con i casi nel lodigiano.
I casi presi in considerazione sono stati 1.591. L’età mediana dei pazienti era di 63 anni: 363 pazienti avevano almeno 71 anni, 203 ne avevano meno di 51. L’82 per cento dei pazienti era di sesso maschile.
Il 68 per cento dei pazienti aveva almeno una comorbidità, cioè la coesistenza di altri problemi di salute. L’ipertensione era la patologia più comune (49 per cento) tra un sottogruppo di 1.043 pazienti per i quali erano disponibili informazioni più dettagliate. La seconda comorbidità erano problemi cardiovascolari (21 per cento) e il colesterolo alto (18 per cento). Solamente il 4 per cento dei pazienti aveva problemi pregressi seri a carico del sistema respiratorio. Tutti i pazienti con più di 80 anni avevano almeno una comorbidità, così come il 76 per cento dei pazienti sopra i 60 anni.
Lo studio fornisce informazioni interessanti su condizioni ed esiti dei ricoveri in terapia intensiva. Su un sottogruppo di 1.300 pazienti con informazioni più dettagliate, il 99 per cento ha avuto bisogno di ventilazione non invasiva (mascherine con ossigeno, caschi) o invasiva (intubazione): la stragrande maggioranza di loro – 1.150 pazienti – è stata intubata.
Il 26 per cento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva nel periodo preso in esame è morto, con una maggiore incidenza della mortalità tra gli individui più anziani. La mortalità tra i pazienti fino a 60 anni è stata del 15 per cento contro il 29 per cento di quella per gli individui da 61 anni in su.
Alla fine del periodo preso in analisi, il tempo mediano di permanenza dei pazienti in terapia intensiva è stato di 9 giorni. Il tempo mediano di permanenza per gli individui morti in terapia intensiva è stato di 7 giorni. Le cause dei decessi sono molto varie e l’incidenza è probabilmente dipesa dal momento del ricovero, rispetto all’avanzamento della malattia e alle condizioni dei singoli pazienti.
Lo studio segnala quindi che circa un paziente ogni quatto ricoverati in terapia intensiva è morto a causa della malattia e delle sue condizioni di salute pregresse (anche se queste non sono sempre state necessariamente un fattore determinante). La maggior parte degli individui in condizioni critiche era di sesso maschile e con età al di sopra dei 64 anni. La ricerca osserva inoltre come la percentuale di pazienti sottoposti a intubazione fosse particolarmente alta se confrontata con i dati messi a disposizione da ricerche svolte in altri paesi sempre sui reparti di terapia intensiva.
L’indagine svolta in Lombardia è importante soprattutto per la quantità dei dati raccolti, che ha permesso di avere un quadro complessivo della situazione nelle terapie intensive finora non disponibile. Gli autori invitano comunque a valutare con cautela alcuni dati, ricordando che lo studio ha qualche limite sia per il fatto di avere raccolto informazioni retrospettivamente, sia per non avere avuto accesso a tutti i dati necessari per ogni paziente.
Lo studio non offre inoltre elementi per valutare la convalescenza degli individui dimessi, né le prospettive per chi continua a essere ricoverato da settimane in terapia intensiva. L’intubazione per un periodo di tempo prolungato può causare forti stress al sistema respiratorio, con danni ai polmoni che richiedono tempi di recupero lunghi e in alcuni casi conseguenze permanenti, che si possono rivelare debilitanti. Il controllo nel medio periodo dei pazienti dimessi dovrebbe offrire nuove informazioni, per comprendere costi e benefici dell’intubazione e per migliorare protocolli e terapie da seguire per i pazienti ricoverati.