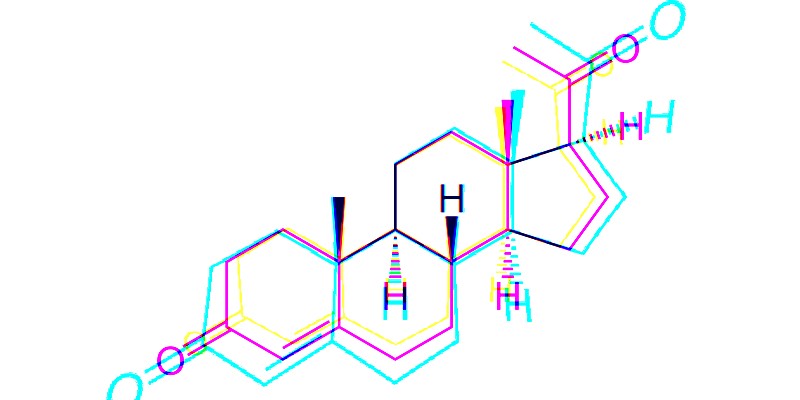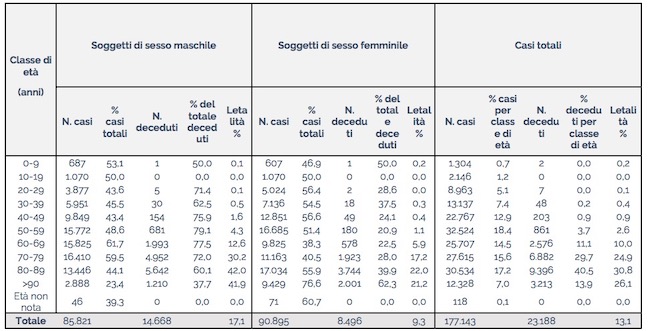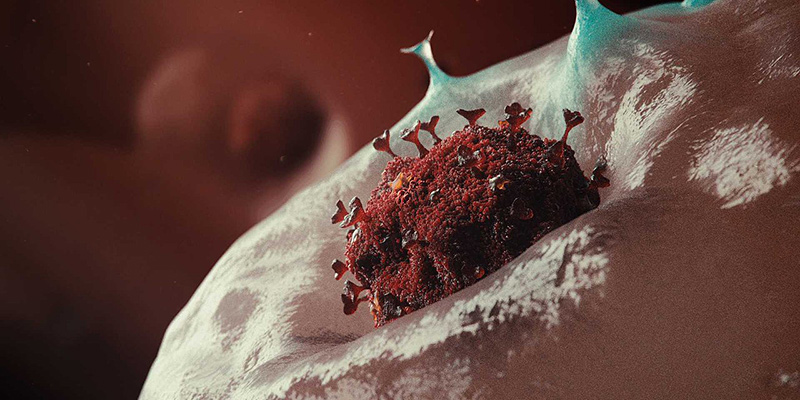Erano stati pubblicati su Lancet e NEJM, tra le più importanti riviste scientifiche in ambito medico al mondo, basandosi su dati che gli stessi autori non hanno potuto verificare.
Lancet e il New England Journal of Medicine (NEJM) – due tra le più importanti riviste scientifiche in ambito medico al mondo – hanno ritirato due studi sulla sperimentazione di farmaci contro la COVID-19, che avevano avuto grandi ripercussioni nella ricerca di nuovi trattamenti contro la
malattia causata dal coronavirus. Uno dei due studi aveva indotto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a interrompere i test con l’idrossiclorochina, un antimalarico che aveva dato alcuni risultati positivi nel trattamento dei pazienti, ma che secondo la ricerca ora ritirata poteva avere in alcuni casi effetti collaterali gravi sui malati di COVID-19.
Non accade spesso che studi pubblicati su riviste di questo livello siano ritirati, e che questo accada così velocemente dopo la loro diffusione. Secondo diversi esperti, la vicenda dimostra come la ricerca di soluzioni per la pandemia abbia portato a una certa frenesia in ambito scientifico e clinico, con la pubblicazione di decine di nuove ricerche ogni giorno e poco tempo per verificarne l’affidabilità anche da parte delle riviste scientifiche più rispettate.
Entrambi gli studi erano stati realizzati dal cardiochirurgo Mandeep Mehra (Brigham and Women’s Hospital, Università di Harvard) insieme ad altri ricercatori, sulla base di un grande set di dati fornito da Surgisphere, una piccola azienda di Chicago gestita da Sapan Desai, indicato tra gli autori delle due ricerche.
Lo studio pubblicato su Lancet aveva segnalato che, in diverse circostanze, l’idrossiclorochina potesse causare più danni che benefici nei pazienti con COVID-19. Il farmaco viene utilizzato contro la malaria ed è in circolazione da diversi decenni: in Italia e in altri paesi è soprattutto noto con il nome commerciale Plaquenil, usato anche per trattare malattie autoimmuni, come il lupus e l’artrite reumatoide. L’idrossiclorochina era finita al centro dell’interesse dei media un paio di settimane fa, quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva detto di avere iniziato ad assumerla come terapia preventiva contro la COVID-19, nonostante la mancanza di evidenze scientifiche circa l’utilità del farmaco per prevenire l’infezione da coronavirus.
Dopo la pubblicazione della ricerca di Mehra su Lancet, diversi ricercatori avevano espresso dubbi circa l’affidabilità dei dati su cui era basata e forniti da Surgisphere. In molti si erano chiesti come avesse fatto un’azienda così piccola, con meno di una decina di dipendenti, ad avere raccolto ed elaborato i dati sanitari di decine di migliaia di pazienti, forniti da centinaia di ospedali con i quali dichiarava di avere avviato collaborazioni. Raccogliere dati sanitari non è semplice e richiede la stipula di contratti molto articolati con ogni ospedale, con specifiche garanzie per la tutela della privacy dei pazienti: appariva quindi improbabile che Surgisphere da sola fosse riuscita a ottenere risultati simili.
Le evidenze scientifiche in una ricerca dovrebbero valere più di qualsiasi curriculum, ma c’è sempre il rischio che la reputazione degli autori di una ricerca condizioni le valutazioni degli altri, almeno nei primi tempi dopo la pubblicazione dei loro lavori. Mehra è un ricercatore molto rispettato e nel corso della sua carriera ha pubblicato centinaia di studi, cosa che potrebbe avere condizionato il modo in cui è stato percepito il suo studio sull’idrossiclorochina. Leggendo le conclusioni del suo lavoro, diversi ricercatori avevano deciso di rivedere o fermare le loro sperimentazioni e la stessa OMS aveva annunciato una sospensione dei test, per precauzione, considerati i rischi indicati da Mehra e colleghi. L’Organizzazione ha da poco annunciato il riavvio delle sperimentazioni.
Lancet ha ritirato lo studio su indicazione degli autori, dopo che Surgisphere si è rifiutata di fornire i dati completi in suo possesso sui pazienti, rendendo impossibile la verifica degli stessi da parte di altri ricercatori non coinvolti direttamente nella ricerca. La società ha comunicato di non potere condividere quei dati a causa degli accordi con gli ospedali con cui collabora. Questa circostanza ha reso impossibile la verifica dei dati e quindi la stessa analisi dello studio.
Anche lo studio ritirato dal NEJM era basato sui dati di Surgisphere: segnalava che l’assunzione di alcuni farmaci per regolare la pressione non comportava un maggior rischio di morte tra i malati di COVID-19, come era stato invece indicato da altri studi. Gli autori della ricerca hanno pubblicato una nota sulla rivista dicendo di non avere avuto accesso ai dati grezzi forniti dall’azienda, e di non essere quindi in grado di avere ulteriori conferme sulla loro qualità. Il dettaglio paradossale è che oltre a Mehra tra gli autori dello studio c’è anche Desai (il capo di Surgisphere), che sembra non abbia accesso alle informazioni trattate dalla sua stessa azienda.
In seguito alla vicenda, Mehra ha diffuso un comunicato a titolo personale, nel quale ha spiegato di essere entrato in contatto con Desai tramite un collega e di essersi poi reso conto di non avere elementi a sufficienza per fare completo affidamento sui dati di Surgisphere: “Non ho fatto abbastanza per assicurarmi che la fonte dei dati fosse adeguata all’uso che ne abbiamo fatto. Per questo, e per tutti i disagi causati – direttamente o indirettamente – chiedo sinceramente scusa”.
La scelta delle due riviste scientifiche di pubblicare le note degli autori degli studi, senza accompagnarle da proprie valutazioni sull’accaduto, è stata criticata da numerosi osservatori. Secondo i più critici, in un momento storico in cui si pubblicano ogni giorno decine di ricerche su una pandemia in corso sarebbero utili valutazioni e introspezioni sugli errori compiuti, soprattutto da parte di riviste molto importanti e rispettate.