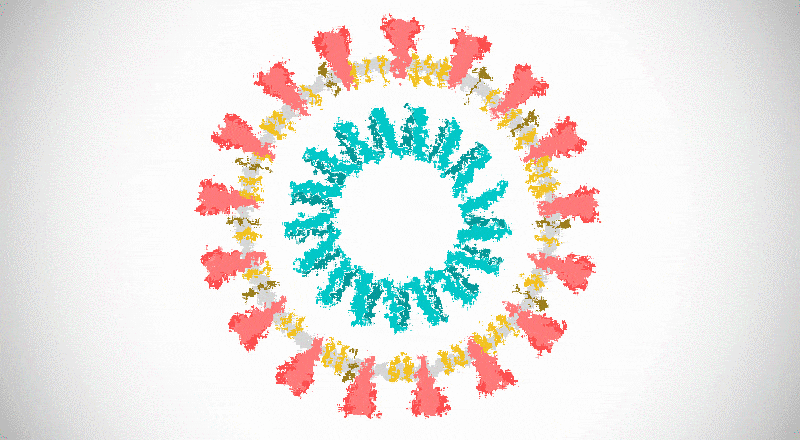È vero che cambia – ed è normale – ma non ci sono ancora elementi per dire che stia diventando più pericoloso, o che possa succedere.
Nell’ultima settimana diversi giornali hanno ripreso uno studio realizzato negli Stati Uniti, sostenendo che abbia portato alla scoperta di un “nuovo ceppo” del coronavirus, più diffuso di quello originario e tale da avere reso il virus più contagioso. In realtà la ricerca citata – realizzata preso il Los Alamos National Laboratory (New Mexico) – utilizza toni cauti e non parla di un nuovo ceppo in quei termini, ma di una mutazione del coronavirus che ha iniziato a diffondersi in Europa all’inizio di febbraio e che si è poi probabilmente diffusa negli Stati Uniti, e che per questo non deve essere sottovalutata.
Lo studio statunitense è stato diffuso nella sua forma preliminare, e non è stato quindi ancora sottoposto a una revisione alla pari da altri scienziati né è stato pubblicato su una rivista scientifica, quindi dovrebbe essere preso in considerazione con qualche cautela aggiuntiva rispetto a quelle già necessarie per le normali ricerche. Secondo diversi ricercatori, che non hanno partecipato allo studio, le conclusioni prospettate sono plausibili ma non rappresentano comunque ciò che è avvenuto finora con la diffusione dell’epidemia.
Il punto centrale per molti ricercatori, come hanno spiegato sull’Atlantic, è che a oggi non ci sono elementi chiari per sostenere che esistano diversi “ceppi” del coronavirus, anche se spesso sui giornali abbiamo letto il contrario. La confusione deriva dal fatto che sui media si confondono quasi sempre mutazioni e ceppi, utilizzando i due termini come se fossero sinonimi.
Mutazioni
Semplificando molto, un virus entra in un organismo e ne sfrutta poi le cellule per replicarsi, cioè per creare nuove copie di se stesso che provvederanno a legarsi ad altre cellule per fare la stessa cosa. Questo meccanismo non è molto preciso e può portare ad alcuni errori nella fase in cui il codice genetico del virus viene trascritto per farne una copia, un po’ come avviene quando si ricopia un testo e inavvertitamente si scrive un refuso. È nell’ordine delle cose, succede di continuo in natura nei processi di replicazione del codice genetico. Il risultato di questi refusi sono mutazioni, quasi sempre innocue e che si trasmettono alle generazioni successive, accumulandosi a quelle nuove prodotte nei processi di replicazione seguenti.
Queste imprecisioni determinano il progressivo allargamento dell’albero genealogico di un virus, con nuovi rami che però non implicano che si sviluppi un nuovo “ceppo virale”. I virologi riservano questa definizione per una nuova generazione di virus che presenta differenze marcate e significative rispetto alle precedenti, soprattutto negli esiti delle sue attività. Anche se non tutti concordano sul limite oltre il quale si possa parlare di nuovo ceppo, vengono tenuti in considerazione criteri come: modificata capacità del virus di diffondersi, aumento della sua capacità di causare una malattia (virulenza), nuova resistenza ai trattamenti farmacologici che prima riuscivano a tenerlo sotto controllo, aumentata capacità di eludere le difese immunitarie dell’organismo.
Una o più mutazioni possono influire sulle caratteristiche che abbiamo appena visto, ma non necessariamente in modo significativo e al punto da sostenere che si sia prodotto un nuovo ceppo virale. E questa è la cosa più importante di tutte, quando si parla di modifiche che avvengono nella struttura del virus, man mano che produce nuove generazioni.
Velocità
Ci sono virus che hanno una spiccata tendenza a produrre nuovi ceppi, attraverso mutazioni che si rivelano quasi sempre significative. È il caso dei virus che causano l’influenza stagionale: in poco tempo mutano al punto da cambiare buona parte della configurazione delle proteine sulla loro superficie, apparendo quindi diversi al nostro sistema immunitario, che non riesce più a riconoscerli e deve ogni volta ricominciare da capo per sviluppare le difese contro l’infezione. Questo è uno dei motivi (insieme alla durata della memoria immunitaria) per cui ci ammaliamo più volte di influenza nel corso della vita, e spiega anche perché ogni anno sia necessario sottoporsi nuovamente a un vaccino, che viene calibrato sui ceppi virali influenzali che circolano di più.
I virus influenzali sono però molto diversi dai coronavirus, che per quanto ne sappiamo tendono ad accumulare mutazioni più lentamente (secondo alcune ricerche sono fino a dieci volte più lenti nel mutare rispetto ai virus influenzali). I ricercatori consultati dall’Atlantic hanno spiegato che l’attuale coronavirus, il SARS-CoV-2, non sembra fare eccezione: è andato incontro ad alcune mutazioni, come prevedibile, ma niente di anomalo. Le varie generazioni non sembrano inoltre presentare differenze significative e, considerata la lentezza con cui muta, saranno necessari molti mesi prima di vedere cambiamenti degni di nota.
Cosa dice lo studio
Lo studio del Los Alamos National Laboratory ha preso in considerazione le mutazioni che riguardano le punte del coronavirus, sulla cui superficie c’è una proteina che elude i sistemi di sicurezza delle membrane cellulari, consentendo al virus di iniettare il suo codice genetico nelle cellule per poi replicarsi. I ricercatori hanno notato che la mutazione D614G comporta un cambiamento nelle molecole che costituiscono queste punte.
Il coronavirus nella versione senza questa mutazione (D) è quella tipica di Wuhan, la città cinese dove è iniziata la pandemia, mentre la variante con mutazione (G) è quella che è emersa a febbraio. Fino a marzo, G era poco comune in giro per il mondo, ma da aprile è diventata la versione preponderante in Europa, nel Nord America e in Australia.
I ricercatori ipotizzano (ed è bene sottolineare “ipotizzano”) che la mutazione abbia reso il coronavirus più trasmissibile e che quindi G sia man mano diventata la variante più presente, proprio perché riesce a diffondersi meglio di D. Per ammissione degli stessi ricercatori non si può però escludere che in realtà la mutazione non abbia determinato nessun cambiamento per quanto riguarda la trasmissibilità, e che quindi i coronavirus nella loro versione G si siano banalmente diffusi di più per puro caso.
E i fattori casuali possono essere molti, come sanno bene virologi ed epidemiologi sulla base dell’evoluzione di altre epidemie in passato. Non si può escludere che la versione G fosse quella portata da alcuni viaggiatori dalla Cina di ritorno in Europa, magari in Italia, dove si è poi deciso un lockdown che ha fatto sì che rimanesse in circolazione la versione con la mutazione rispetto all’altra. Il virus sarebbe poi finito in circolazione in altri paesi, dove magari era ugualmente arrivato in quella variante dalla Cina per altre vie, determinando l’epidemia in Europa e il suo arrivo negli Stati Uniti.
Caso
Nelle prime fasi che determinano un’epidemia il caso ha spesso un ruolo importante. Varianti di un virus con mutazioni che, sulla carta, li renderebbero molto più pericolosi finiscono per sparire banalmente perché uno o più individui infetti con il virus mutato restano nello stesso luogo o hanno una scarsa vita sociale. In altre circostanze, virus privi di mutazioni che li rendono più trasmissibili finiscono lo stesso per diffondersi di più, banalmente perché sono presenti in contesti con maggiore socialità o concentrazioni di individui, dovute per esempio alla densità abitativa.
Lo studio del Los Alamos National Laboratory segnala giustamente la prevalenza di una variante su un’altra, ma non fornisce elementi (perché a questo stadio ancora non ce ne sono) per concludere se G si sia diffusa di più perché comporti una maggiore trasmissibilità o solo perché uno o più eventi casuali ne abbiano determinato la prevalenza in alcune aree geografiche.
Per capirlo saranno necessari altri studi, dedicati sia all’analisi della diffusione del coronavirus nella popolazione, sia con test di laboratorio per verificare se G effettivamente sia in grado di legarsi più facilmente alle cellule, o di determinare in qualche modo tempi di replicazione più rapidi. Entrambi questi approcci richiederanno mesi di ricerche e non è comunque detto che portino a risultati chiari e condivisi.
L’opinione prevalente tra i virologi è che non sapremo ancora per diverso tempo se esistano veri e propri ceppi diversi dell’attuale coronavirus. E anche nel momento in cui si determinasse la loro esistenza, occorrerebbero poi altre analisi per verificare se alcuni ceppi comportino più rischi di altri.
Allarmismo e responsabilità
Anche a causa di alcuni prodotti culturali come film e romanzi catastrofisti, siamo abituati all’idea che la mutazione di un virus implichi sempre qualcosa di negativo. La trama di molti film sulle epidemie parte spesso da un agente infettivo tutto sommato poco pericoloso che poi muta, apparentemente dal giorno alla notte, diventando una minaccia senza precedenti. Come abbiamo visto, in realtà molti virus mutano lentamente e non sempre gli errori nella trascrizione del loro codice genetico comportano un vantaggio evolutivo, che grazie al caso consente loro di prosperare.
I virus eccessivamente aggressivi, che causano malattie molto gravi come l’Ebola, tendono a produrre epidemie molto più contenute, proprio perché determinano negli organismi che infettano reazioni tali da ridurre o i loro contatti sociali (malattie che costringono quasi sempre a letto) o un alto tasso di letalità, quindi con una minore circolazione del virus nel tempo. Le mutazioni che non variano l’aggressività dei virus, ma li rendono più contagiosi, offrono di solito qualche opportunità in più in termini di diffusione. Ma molto dipende appunto dal caso, e dalle circostanze in cui avvengono le mutazioni.
Sostenere troppo alla leggera che un virus sia mutato e abbia portato a un nuovo ceppo può anche essere pericoloso, in termini di comunicazione e di decisioni politiche. I governi dei paesi in cui un’epidemia non è tenuta adeguatamente sotto controllo potrebbero scaricare parte delle loro responsabilità su queste mutazioni, sostenendo che il mancato controllo dei contagi sia dovuto a cause esterne alle politiche per il contenimento che hanno scelto.